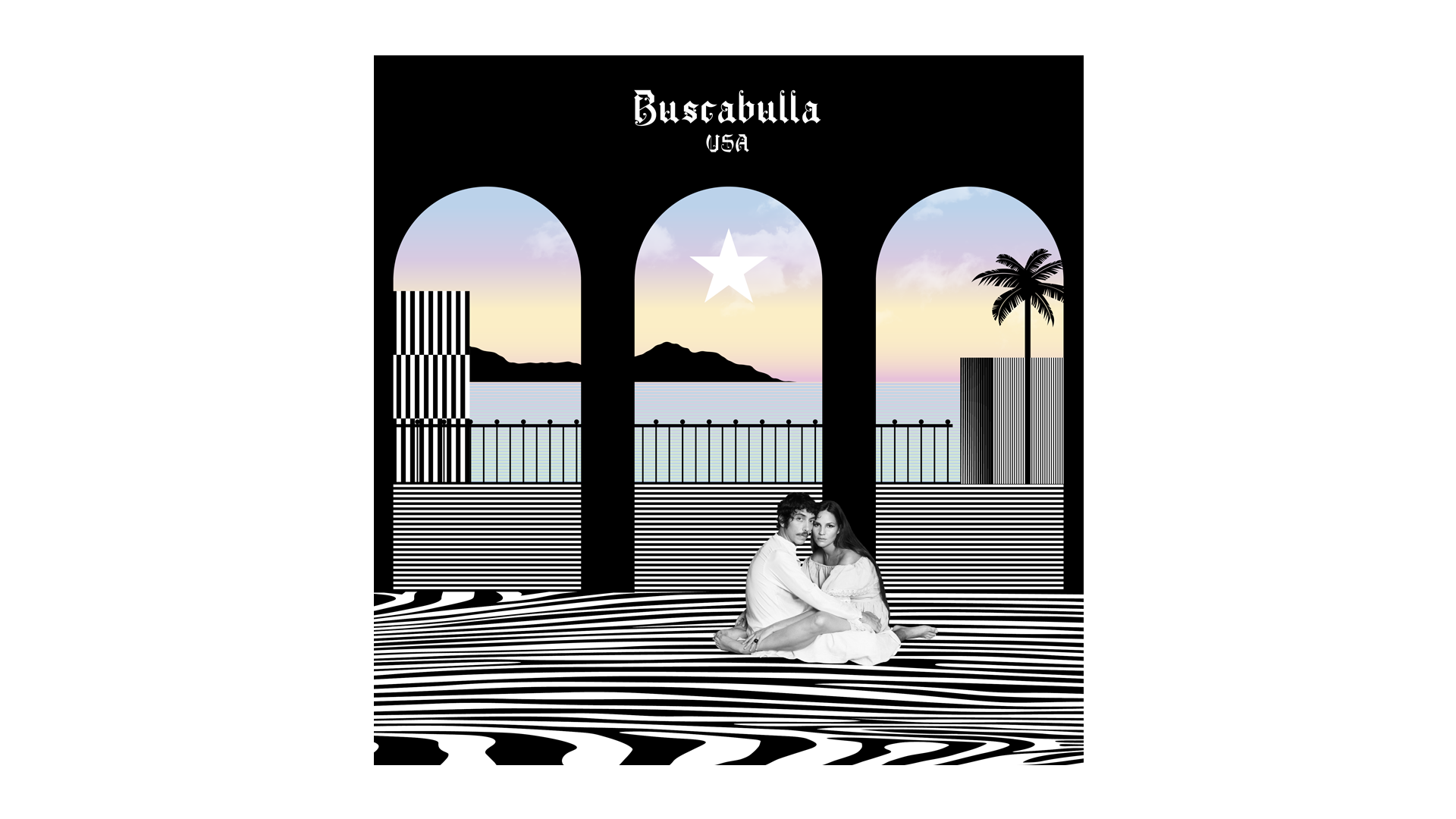di Gabriele Naddeo
Illustrazione di Thomas Borrely
Dopo aver pubblicato due EP e suonato al Coachella 2018, Raquel Berrios e Luis Alfredo Del Valle, in arte Buscabulla, hanno lavorato per circa due anni al primo LP del duo, “Regresa”, pubblicato a maggio 2020 per la Ribbon Music, etichetta della Domino. Il ritorno a cui allude il titolo del disco è la decisione presa dalla coppia di lasciare New York, dopo 10 anni vissuti lì, per tornare nell’amata Porto Rico. L’isola, territorio non incorporato degli Stati Uniti d’America, fa da tempo i conti con crisi economica, disastri ambientali e corruzione politica. Eppure, come mi racconta Raquel per telefono, qualcosa sta cambiando e Porto Rico resta un luogo magico, come i coloratissimi video del gruppo dimostrano ampiamente. Mescolando salsa, reggae, bolero, contemporary R&B ed elettropop, i Buscabulla hanno immaginato un nuovo suono caraibico, caldo e tropicale che, accorciando le distanze tra tradizione e sperimentazione, punta a liberare la Latin music da chi la vuole ancorare ai soliti stereotipi.
(CLICCA QUI PER LEGGERE LA VERSIONE IN INGLESE)
La copertina di “Regresa”
Mi piacerebbe partire dalla copertina di “Regresa”. In quella foto c’è tanta bellezza quanto un senso di rovina. Come nasce lo scatto? Cosa rappresentano i vestiti che avete scelto?
La foto in copertina è stata scattata a Ponce, città natale di Luis, di fronte a uno dei nostri edifici preferiti del posto: un palazzo che, come si vede dallo scatto, è purtroppo in rovina. I vestiti sono ispirati alla tradizione del carnevale dell’isola. Sono gli abiti dei cosiddetti vejigantes, personaggi folklorici delle celebrazioni carnevalesche, che di solito comprendono anche una maschera. Li abbiamo scelti perché ci piaceva l’idea che da materiali economici e di scarto venissero fuori abiti maestosi, con uno stile quasi regale. Per un verso quei vestiti rappresentano la nostra speranza e le nostre aspirazioni di vedere Porto Rico vivere un futuro più sereno e gioioso. C’era però anche il desiderio di creare un contrasto tra quei vestiti così elaborati e il palazzo in rovina alle nostre spalle. Il palazzo in questo senso è un po’ il simbolo degli aspetti “in rovina” nell’isola: Porto Rico sta vivendo una forte crisi economica da circa dieci anni, senza contare che l’isola è stata colpita da disastri naturali, come l’uragano Maria del 2017. Quello scatto è allora un misto di malinconia e speranza.
Le celebrazioni del carnevale di Porto Rico sono anche una delle influenze estetiche più evidenti nelle vostre clip. Oltre ai vestiti, qual è la storia dei carri di carnevale? Da dove spunta fuori la tradizione delle impennate dei carri?
Il carnevale di Porto Rico è semplicemente meraviglioso. Mi affascina molto sopratutto perché è un misto di culture diverse. È frutto di tradizioni locali, così come dell’influenza europea e statunitense. Negli anni le celebrazioni si sono evolute e modernizzate. Un tempo c’erano i carri trainati dai cavalli, poi sostituiti con i carri a motore che si vedono nel video di Vamono e che sfilano per la città a ritmo di reggaeton. A decorare e a far impennare i carri sono le cosidetti gang, ognuna con il proprio stile e i propri vestiti. Pensa che le gang aggiungono decorazioni persino nella parte sottostante del carro, così da mostrarle solo quando fanno le impennate. Ci sono molte leggende metropolitane al riguardo, ma nessuno sa veramente quando è perché sia nata la tradizione delle impennate dei carri. C’è chi dice che risalga a circa 20 o 30 anni fa.
Frame del videoclip di Vámono
Oltre al carnevale, mi sembra che nei video di Vamono e Mìo ci sia anche l’influenza del live show Homecoming di Beyoncé..
Abbiamo suonato al Coachella 2018 quindi abbiamo anche avuto modo di vedere la performance di Homecoming dal vivo. Quindi sì, senz’altro è stata una fonte d’ispirazione. La cosa interessante è che ci siamo trasferiti a Porto Rico e abbiamo cominciato a lavorare a “Regresa” proprio in quell’anno, quindi l’idea stessa di homecoming aveva un senso molto forte per noi.
Dal punto di vista dell’arrangiamento, “Regresa” miscela con gran gusto contemporary R&B, Latin music, tropical ed elettropop. L’album è stato missato da Patrick Wimberly, già collaboratore di Solange per “A Seat at the Table” e Blood Orange per “Freetown Sound”. In che modo avete sviluppato il sound del disco? Cosa vi ha ispirato in particolare?
Sicuramente volevamo connetterci di più con l’isola e in questo senso dare vita a un suono dai tratti molto caraibici. Volevamo un sound molto emotivo, in grado di evocare tanto l’isola quanto la nostra transizione da New York a Porto Rico. Tuttavia, non abbiamo studiato la cosa a tavolino, abbiamo semplicemente tirato fuori alcune canzoni, ognuna con il proprio stile e poi selezionato in un secondo momento quelle che volevamo includere nel disco. Quando però abbiamo scelto i brani definitivi e riascoltato il tutto ci siamo resi conto di un pattern, di una storia che veniva raccontata attraverso la musica. Lavorare con Patrick al missaggio dell’album per noi è stata una specie di chiusura di un cerchio. Patrick era in un gruppo che ci ha influenzato moltissimo, quindi l’idea di aver svilupato l’album a Porto Rico e averlo missato poi a New York ha solamente rinforzato questa nostra transizione tra i due luoghi.
Nel complesso, posso dirti che quando io inizio a lavorare a un disco nuovo uso molto Pinterest, perché lì posso mettere insieme spunti molto diversi, da canzoni a video YouTube. Non mi troverei bene a creare solo delle playlist per avere una lista di spunti sonori e basta, perché ho bisogno anche dell’aspetto visuale che per esempio è molto forte su YouTube. In questo modo su Pinterest posso raggruppare media diversi in un unico spazio. Per “Regresa” avevamo voglia di mescolare i suoni caraibici, come la salsa, il bolero, il reggae e il sound tipico del carnevale, a influenze diverse, come il funk somalo, la musica africana o anche la musica giapponese sperimentale. Cercavamo un suono che fosse caldo e tropicale, abbiamo immaginato una specie di nuovo sound caraibico. Ci sono senz’altro anche influenze reggaeton, diciamo che in base alla canzone abbiamo deciso in che modo mischiare i generi tra loro.
Il successo internazionale della Latin music deve sicuramente tanto al reggaeton e Porto Rico ha avuto un ruolo preminente al riguardo. Però negli ultimi anni stanno uscendo allo scoperto tante sfumature molto diverse della musica Latin. Penso ad artisti come Helado Negro e Lido Pimienta, oltre ai protagonisti dell’urbano sound come Bad Bunny, 070 Shake, Princess Nokia, Rosalìa eccetera. Credi che usare il termine Latin riferendosi a una serie di artisti molto diversi tra loro, accomunati solo dal cantato in spagnolo, sia una riduzione? O al contrario è un’etichetta di cui andare fieri perché segno di appartenenza a una comunità?
Questo è un dibattito interessante che credo abbia soprattutto a che vedere con il modo in cui ci si approccia alla musica. Se ci pensi nessuno parla di una generica musica americana pensando ai tanti generi prodotti in America. Si parla di hip hop, di musica country, rock eccetera. Quindi il fatto di usare un’etichetta come Latin ha senz’altro a che vedere con un senso di diversità, di estraneità, perché come sappiamo chi ha in mano l’industria musicale è statunitense o europeo. Quindi il termine Latin rimanda in un certo senso a un’idea di minoranza. Secondo me poi la cosa strana per noi artisti che facciamo musica latina mainstream è il non sentirsi sempre veramente capiti. Perché da un lato c’è una richiesta sempre maggiore di musica Latin e dell’immaginario latino, ma ciò che in realtà si vuole sono gli stereotipi. Quindi se sei latino e stai provando a sviluppare un suono più sperimentale, più bizzarro come dico io, e che vada oltre i cliché, hai la sensazione che le persone non siano ancora pronte per questo. Però credo che sia più che altro un problema di rappresentanza e che perciò quanto più spazio e visibilità daremo a questi artisti che fanno musica latina sperimentale quanto più questi suoni verranno percepiti come normali.
Per fare un esempio, io credo che Almodovar sia stato in grado di cambiare il modo in cui si percepisce la Spagna con il suo stile cinematografico così particolare. Certo, è un processo che ha avuto bisogno di tempo, ma adesso quando qualcuno pensa alla Spagna lo fa anche pensando ad Almodovar, applica anche quel filtro lì. Il modo in cui processiamo l’America Latina deve allora necessariamente andare oltre gli stereotipi, la sala, gli ayayay e il reggaeton. C’è così tanto da raccontare e quasi nessuno lo fa. La mia sensazione è che adesso siamo in fase di costruzione, stiamo sviluppando questo suono latino alternativo che prima o poi diventerà parte di ciò che noi percepiamo come Latin music. C’è ancora tantissimo da fare però.
Invece cosa ne pensi del dibattito della lingua spagnola inclusiva? Oggi si usa il termine Latino, ma da qualche anno è in corso una discussione molto sentita riguardo l’introduzione delle varianti Latinx o Latine. Tu che ne pensi?
È molto complesso, considerando che il dibattito esiste, ma non è stato approvato dall’istituto ufficiale della lingua spagnola. Posso sicuramente dire che capisco perché le nuove generazioni sentano il bisogno di nuove parole per definirci. Devo dire che non sono convinta del fatto che un termine sia migliore dell’altro, perché credo che siamo ancora in una fase di transizione. Tra l’altro, per tornare a quello che dicevamo prima sul termine Latin, oltre alla questione di genere credo che sia veramente difficile inglobare in un’unica etichetta tutte le sfumature del mondo latino. D’altronde la Spagna ha colonizzato un continente intero e le differenze culturali da un Paese all’altro sono tante. A questo poi ora va aggiunta anche la generazione degli American-Latinos. È ancora un processo aperto e anche in questo caso si avrà bisogno di tempo. Che poi, credo che nell’Unione Europa in un certo senso stia avvenendo un processo simile. Eppure, posso immaginare che molte persone in Italia si considerino solo italiane e basta, piuttosto che europee. La questione, secondo me, è in ogni caso una: oltre alla lingua – e quindi nel caso del mondo Latino oltre al fatto di essere stati colonizzati – cos’è veramente che condivide la nostra comunità? Cos’è che ci tiene uniti?
Avete vissuto a New York per 10 anni, prima di scegliere di tornare a Porto Rico, una decisione che è diventata anche la tematica centrale alla base del vostro disco. Leggevo che sono più i portoricani che vivono negli Stati Uniti di quelli rimasti nell’isola. Voi perché avevate deciso di trasferirvi a New York? Perché poi siete tornati indietro?
Io e Luis ci siamo trasferiti a New York per motivi diversi. Io avevo studiato architettura a Porto Rico e volevo spostarmi lì per continuare con degli studi in design tessile. Così ho seguito un master a Rhode Island e poi lavorato nel settore. New York è sempre stata una città in cui volevo trasferirmi. Porto Rico è un’isola piccola e dieci anni fa sentivo che New York era il posto perfetto per me. Avevo il lavoro come designer tessile, poi ho iniziato a lavorare come DJ e in vari negozi di dischi, soprattutto è il luogo in cui la band si è formata. Tutte le motivazioni e i sogni per cui mi ero spostata lì si erano avverati. Anche le motivazioni di Luis erano simili: si era trasferito a New York per studiare ingegneria del suono e produzione musicale, oltre che naturalmente per suonare, che poi è anche il modo in cui ci siamo conosciuti. Ora, il motivo per cui dopo dieci anni abbiamo deciso di tornare a Porto Rico è perché non abbiamo mai smesso di pensare all’isola. Quando ho lasciato Porto Rico è come se una parte di me fosse rimasta lì. È un posto veramente speciale: un’isola tropicale con spiagge stupende e persone molto socievoli, certo non è un posto in cui è facile vivere, ma è sicuramente piacevole. Soprattutto, non funziona con lo stesso ritmo frenetico di New York.
New York può essere un città veramente tosta per chi viene dai Caraibi, basta pensare al freddo, al lavoro non-stop, al non sentirsi in contatto con la natura. Negli ultimi tempi la vita lì ci sembrava particolarmente dura: è difficile avere dei lavori a tempo pieno, una bambina e una band. Quando avevamo dei concerti era molto faticoso: il dover coordinare la baby sitter, il lavoro, il carico e scarico degli strumenti e dell’attrezzatura per i live, girare con la macchina per trovare un parcheggio, poi svegliarsi la mattina dopo alle sei di mattina per andare a lavorare…Porto Rico dalla sua ha che la vita è più economica, poi ora abbiamo la famiglia vicino, il tempo è magnifico. Volevamo crescere nostra figlia qui e volevamo realizzare il nostro sogno di avere un piccolo studio musicale in casa. Così quando abbiamo firmato il contratto con l’etichetta abbiamo deciso che era arrivato il tempo giusto per tornare. Anche dal punto di vista pratico non è male: la città in cui viviamo ora ha un aeroporto ben connesso con New York, Texas, Miami eccetera.
C’è una nota citazione di Gabriel García Márquez che dice: “La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”. Voi come avete ricordato o raccontato Porto Rico mentre eravate a New York? Com’è stato invece il ritorno?
Ho la sensazione che Porto Rico ponga una specia di incantesimo su chi è lontano dall’isola. È un posto magico e quando sei via da lì è come se l’immagine ideale di Porto Rico abbia la meglio sul resto. Così quando lasci l’isola hai solo in mente i ricordi più dolci, le feste – il Natale qui è stupendo! – il modo in cui le persone socializzano. Si tende quindi a dimenticare tutto ciò che nell’isola non va: il livello di criminalità, la corruzione politica, la crisi economica e la mancanza di lavoro, gli edifici abbandonati. Una volta tornati qui ci siamo senz’altro scontrati con la realtà. Anche se eravamo felicissimi di tornare e di essere con la nostra famiglia, è stato un cambio non indifferente passare da New York a Porto Rico. I primi mesi sono stati molto duri, ci siamo sentiti anche un po’ soli: molte persone che conoscevamo nel frattempo si erano spostate ed è stato come ripartire da zero, considerando anche che ci siamo trasferiti in una città diversa da quella in cui siamo cresciuti io e Luis.
Com’è la vostra vita a Porto Rico adesso, a due anni dal trasferimento? Vi dedicate ad altro oltre al progetto musicale?
Al momento ci dedichiamo al 100% alla musica. Come ti dicevo, abbiamo deciso di tornare qui nel momento in cui abbiamo firmato il contratto discografico. Era il cambio che stavamo aspettando e – toccando ferro – finora è andato tutto bene. Quest’anno ovviamente è stato assurdo: dopo esserci trasferiti qui con nostra figlia, aver preso la decisione di dedicare il nostro tempo al progetto e lavorato per due anni al disco cosa succede? Scoppia la pandemia. Non ci potevo credere. Sarebbe stato un anno molto diverso se avessimo avuto la possibilità di andare in tour, ma fortunatamente finora è andato tutto bene. Abbiamo pubblicato il disco, ha ricevuto riscontri molto positivi dalla critica e in un certo senso la pandemia ha dato all’album un senso completamente diverso. Abbiamo ricevuto messaggi di persone che ci ringraziavano perché “Regresa” le ha aiutate a non sentirsi depresse durante la pandemia.
Mentre parla Raquel si sente all’improvviso un rumore molto forte in lontananza. Mi spiega che sono i veicoli pubblicitari noleggiati dai politici per fare promozione in tempo di elezione.
Coincidenza perfetta, dato che volevo giusto farti un paio di domande sulla politica di Porto Rico. L’isola ha una realtà politica molto particolare, essendo un territorio incorporato degli Stati Uniti, ma non uno stato a tutti gli effetti. Tu cosa pensi al riguardo? Tu e Luis avete supportato pubblicamente come Buscabulla un partito o un candidato per le elezioni governative di Porto Rico dello scorso 3 novembre?
Così come per i Democratici e i Repubblicani negli Stati Uniti, anche noi non abbiamo avuto in genere altri partiti oltre ai due principali. Per queste elezioni però si sono presentati due ottimi candidati che non fanno capo a nessuno dei due partiti in questione. Uno è del Partito Indipendista Portoricano e l’altra è di un partito formatosi di recente, il Movimiento Victoria Ciudadana. Ci sembravano entrambi buoni candidati quindi non volevamo supportarne solo uno pubblicamente per non influenzare il voto.
Ti stai riferendo a Juan Dalmau e Alexandra Lúgaro?
Sì, esatto, loro due. Sono in gamba e anche ai dibattiti hanno fatto una bella figura. Credo che rappresentino la sensibilità che sia io che Luis proviamo per l’isola. Soprattutto, il fatto che ci siano due buoni politici estranei ai partiti tradizionali è secondo me un fattore di cambiamento positivo per Porto Rico. In un certo senso loro per me rappresentano quello che Bernie Sanders è negli Stati Uniti. Anche se non ha vinto e non è stato scelto come candidato del partito, c’è comunque un grande movimento attorno a lui, moltissime persone che credono in lui e credo che negli anni vedremo questo movimento crescere ancora. Ho la sensazione che a Porto Rico stia succedendo qualcosa di simile e che questi due candidati vedranno man mano accrescere il loro consenso.
Cosa ne pensi invece dei referendum sulla possibilità di essere riconosciuti come stato ufficiale degli USA?
Il Partito Progressista vuole che Porto Rico sia riconosciuto come stato USA e più o meno ogni quattro anni promuove un referendum al riguardo. Ormai è quasi una barzelletta, perché il governo statunitense continua a dire di non essere interessato alla questione per il momento, quindi la sensazione è che il partito usi i soldi pubblici a scopo puramente politico. Per far credere alle persone che Porto Rico verrà riconosciuto effettivamente come stato un giorno. Noi pensiamo che ciò che il Partito Progressista voglia veramente siano solo i soldi degli USA e che se mai dovesse arrivare il tempo in cui l’isola verrà riconosciuta come stato membro a tutti gli effetti loro sarebbero terrorizzati all’idea. Quello che secondo noi stanno facendo è manipolare le persone con il sogno dell’annessione agli USA.
In generale, per quanto riguarda il rapporto tra USA e comunità latina, Luis dice sempre che secondo lui nei prossimi 50 anni si assisterà a una progressiva crescita del potere politico della comunità latina e che potremmo avere di fatto Latinos a capo degli Stati Uniti. D’altronde, non penso che sia improbabile che AOC (Alexandria Ocasio-Cortez, ndr), che ha origini portoricane, un giorno potrebbe diventare la presidente degli USA. In quel caso sarebbe molto interessante capire cosa succederebbe, sarebbe senza dubbio un evento che cambierebbe le regole del gioco. Di pari passo con la crescita della comunità latina e del suo maggiore peso negli Stati Uniti, sta poi crescendo anche la richiesta di Latin music e di gruppi Latin. Noi abbiamo sicuramente tratto beneficio da questa situazione, ma secondo me ora è fondamentale essere molto attenti al riguardo e capire cosa possiamo fare per rappresentare al meglio la nostra comunità, nel nostro caso Porto Rico, senza svendersi e essere manipolati dalle imprese che cercano banalmente di vendere i propri prodotti alla comunità latina.